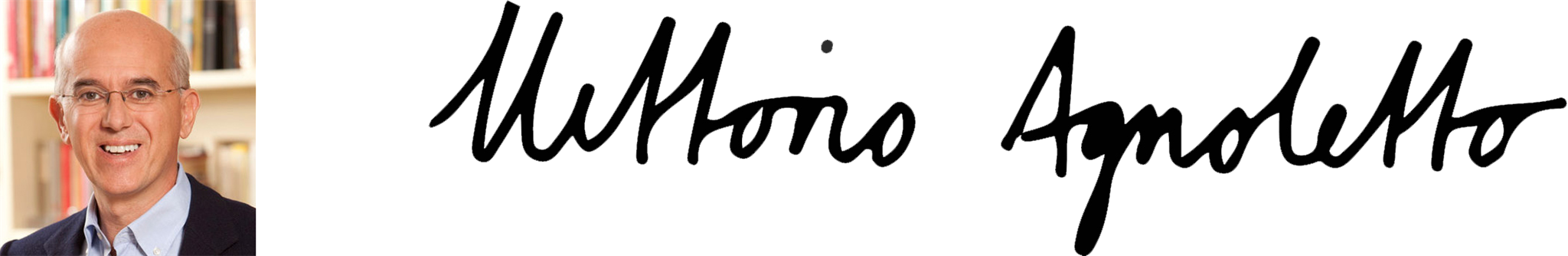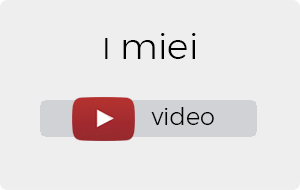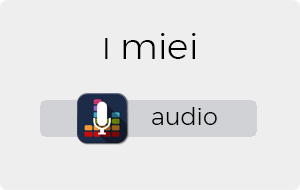Israele, il razzismo, le guerre
Israele
Non capita spesso di poter assistere in un festival ufficiale a un film che critica apertamente e pone sotto accusa qualche aspetto della società israeliana senza che le autorità di quel paese o qualche associazione sollevi vibrate proteste, accusando i registi di antisemitismo e chiedendo il ritiro della pellicola.
Questo non è accaduto fino ad ora per M, il film della regista francese Yolande Zauberman, premio speciale della giuria, che offre uno spaccato interessante delle violenze sessuali sui minori a Bnei Brack, la capitale degli Haredi, gli ebrei ultra-ortodossi, “i timorati di Dio” in ebraico. Uno spaccato interessante del maschilismo e dell’omertà presenti in comunità integraliste, rinchiuse in se stesse, dominate dal potere dei rabbini che, come in ogni stato, rappresentano anche la legge.
Film esplicito, che supera agilmente più di un tabù e che segue il percorso di un giovane violentato da bambino, che partendo da sentimenti di autocolpevolizzazione avvia un percorso di liberazione interiore che sfocia nell’outing. Pur riportando interviste e dichiarazioni alquanto esplicite, la regista si astiene da ogni giudizio etico, esaltando in tal modo la forza del racconto. L’unico rischio derivante da alcuni colloqui, presenti in particolare nella fase iniziale del film, è quello di essere spinti a credere che omosessualità e transgender siano il risultato di violenze sessuali subite in età infantile, ma nulla ci fa pensare che questo sia il pensiero della regista.
Hatzlila di Yona Rozenkier è anch’esso un film ambientato in Israele e racconta l’incontro in un kibbutz di tre fratelli prima delle partenza di uno di loro per l’ennesima campagna in Libano. Il film appare confuso, privo di una trama che abbia una minima solidità. L’unico elemento che accompagna tutto il film è la presenza delle armi in ogni momento della giornata; una vita quotidiana nella quale domina un rapporto simbiotico uomo/fucile- pistola-mitragliatore.
Guerre
Due i film su Ceylon, ambedue centrati sui Tamil, sulla fine del conflitto e la necessaria ripresa del dialogo. Due pellicole molto diverse fra loro.
Demons in Paradise di Jude Ratnam, nei primi minuti accenna ai motivi che hanno segnato l’inizio del conflitto, ma tutto il film è concentrato sul racconto degli scontri interni alle varie fazioni Tamil, della loro assurdità ed in particolare sulle responsabilità del maggior gruppo armato tra i Tamil, le Tigri. Per chi, come me, vive da lontano la storia che viene raccontata forse non è questo l’aspetto fondamentale con il quale ci si aspetta di venire in contatto in un festival internazionale, tanto più che una strana sensazione ti assale ad un certo punto della visione: quello di essere tirato dentro un regolamento di conti tra diverse fazioni presenti tra i Tamil.
Thundenek dei registi Asoka Handagama, Vimukthi Jayasundara e Prasanna Vithanage, appare come un’opera molto più completa e articolata che si svolge attraverso tre episodi: la difficoltà del comunicare la morte in guerra del suo uomo a una giovane donna dello schieramento avversario; la supposta reincarnazione di un guerrigliero Tamil in un bambino ed infine le madri che manifestano nella capitale chiedendo notizie dei figli e dei mariti dispersi durante la guerra. Ne esce un quadro a più scene sulla difficoltà del periodo post bellico, sugli enormi ostacoli presenti sul cammino verso una possibile riconciliazione, che difficilmente potrà realizzarsi senza che prima ognuno abbia potuto seppellire i propri morti, come insegna l’esperienza delle Madri della Plaza de Mayo. Un film avvincente e interessante, tra storia e cultura.
Altri due film ambientati in paesi in guerra e anch’essi fra loro molto diversi, certamente non mancheranno di suscitare dibattiti e polemiche tra gli spettatori.
In Zanani ba gushvarehaye baruti (Women with gunpowder earrings) il regista iraniano Reza Farahmand racconta la condizione delle donne irachene e siriane durante la guerra contro l’ISIS. Inizialmente si è coinvolti dall’emozione di essere in prima linea, nel mezzo di un combattimento tra bombe che esplodono, agguati, morti e feriti, ma con il trascorrere dei minuti comincia a sorgere qualche interrogativo: com’è possibile che una donna, la giornalista, superi tutte le linee di guerra, sia in prima fila, dia ordini ai soldati, indichi i percorsi agli ufficiali, si faccia intervistare qualche secondo dopo la morte o comunque il ferimento del proprio collega fotografo ecc. ecc.?
Sorge il dubbio di trovarsi in una sorta di fiction girata certamente sul set di una guerra vera, dove uno degli intenti sia quello di trasformare in eroina la giornalista protagonista del film documentario. A rendere più complessa la vicenda le risposte reticenti del regista sul ruolo e sui suoi rapporti con la giornalista; inoltre, dopo aver affermato che tutto è stato girato in diretta, sempre il regista ha dichiarato che alcune delle interviste realizzate nei campi profughi con le donne dei combattenti dell’ISIS hanno dovuto essere girate più volte perché le donne difendevano le scelte dei loro uomini. Non era ovviamente questa la risposta politicamente corretta che il regista e i produttori volevano ascoltare.
Resta quindi il dubbio di una pellicola con una forte componente propagandistica; precisato questo, non c’è dubbio che soprattutto le scene girate all’interno dei campi profughi siano decisamente interessanti e ci permettano di venire in contatto con aspetti di quel conflitto a noi sconosciuti.
Laila at the Bridge, produzione Canada/Afghanistan, regia dei coniugi afgani Gulistan ed Elizabeth Mirzaei, è un film che coinvolge e che indubbiamente suscita simpatia verso la protagonista Laila, “la madre dei tossici”: una donna che raccoglie eroinomani ridotti a vivere per strada, sotto i ponti, tra i cartoni e ormai abituati a bucarsi in qualunque parte del corpo, lì dove scorre una vena ancora integra. Una donna che si muove da sola nel paese che ancora oggi è il maggior produttore al mondo di oppio e dove il traffico di questa sostanza contribuisce ad arricchire, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ognuna delle parti in conflitto, compreso ovviamente chi siede sulle poltrone del governo. Una donna abituata a discutere con il potere, capace di farsi rispettare e di trovare le risorse economiche per mandare avanti la propria impresa. I dubbi sorgono quando il film approfondisce le modalità con le quali cerca di sottrarre le persone all’eroina: né metadone, né altri farmaci, ma docce fredde e rasatura totale…
E infine un film su Gaza
L’Apollon de Gaza, produzione Svizzera/Canada di Nicolas Wadimoff, narra come nel 2013 una statua di Apollo risalente ad oltre 2000 anni fa viene ritrovata al largo di Gaza e poi scompare improvvisamente. Il film ruota attorno all’inaspettato ritrovamento che testimonierebbe il ruolo culturale svolto da Gaza nell’antichità. Ma la statua scompare e non si ritrova; si susseguono le ipotesi su chi possa essersene appropriato: il governo della Striscia di Gaza? Un gruppo militare che proverà a rivenderlo per ottenere finanziamenti ? L’indagine sulla scomparsa offre l’occasione per mostrare altri reperti archeologici conservati in vari capannoni, per mostrare le sedi istituzionali culturali funzionanti e non distrutte, per mostrare un volto inedito di una città spesso rappresentata solo tra rovine, bombardamenti e massacri, in un presente tragico e privo di radici storiche. Ed è questa dimensione storica restituita a Gaza l’aspetto più interessante di un film per la verità un po’ ripetitivo e monotono nel suo incedere.
Razzismo e destre
BlacKkKlansman di Spike Lee ha vinto un meritatissimo premio del pubblico. Un film avvincente, che prendendo spunto da una storia vera mette a nudo i meccanismi interni di funzionamento del potere e la tolleranza delle Stato americano verso il Ku Klux Klan. Parla del passato, ma il presente irrompe con forza nelle scene finali e non c’è nulla da spiegare, tutto è già stato detto, tutto è già accaduto.
Wintermaerchen (A winter‘s tale), regia di Jean Bonny, è una descrizione di un gruppo di estremisti di destra in Germania che trascorrono il tempo tra gli attentati verso gli immigrati, grandi bevute d’alcool e un’attività sessuale frenetica e con vari intrecci tra generi differenti. Nessun riferimento al contesto sociale, non un’immagine o una parola sulle reazioni delle istituzioni o sulla rete associativa che li sostiene. Tutto è racchiuso nel microcosmo dei tre protagonisti, che col procedere della storia sembrano sempre di più delle persone con gravi problemi psichiatrici. Un film a mio parere insignificante e privo di qualunque costrutto.